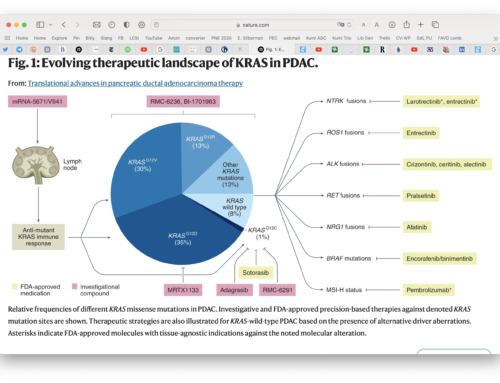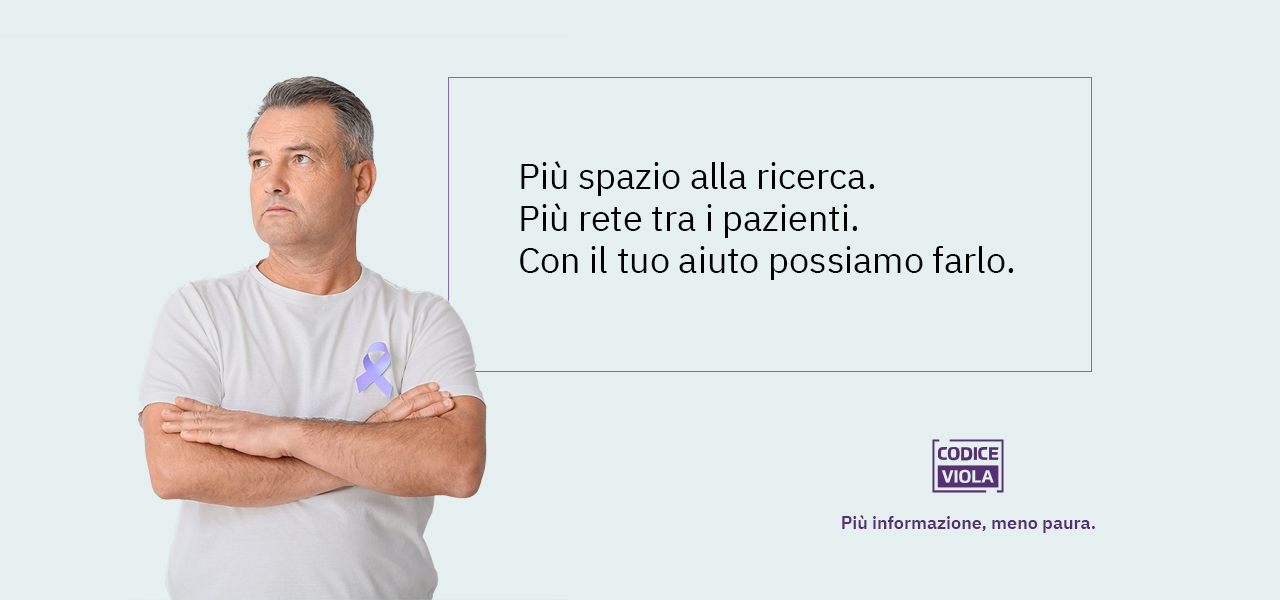Andrea Spinelli, 44 anni, da più di quattro anni convive con un tumore al pancreas non operabile. Tutte le innumerevoli difficoltà creategli da questa complessa patologia non gli hanno precluso il progetto di attraversare l’Italia e l’Europa a piedi. Il suo motto: Buona Vita a Tutti!
Come hai scoperto di avere un tumore al pancreas
17 Ottobre 2013 un amico mi fa notare il colore giallo dei miei occhi. La stessa notte mi sono venuti dei forti dolori all’addome e il mattino alle 3 decido di andare al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pordenone.
Era il 17 ottobre, sempre del 2013, tardo pomeriggio; stavo fumando una sigaretta del mio secondo pacchetto, parlavo del più e del meno con un amico, quando a un tratto mi ha fatto notare, «Sai Spino – gli amici mi chiamano con questo soprannome – hai gli occhi gialli». Al momento non ho dato tanto peso alla cosa e ho risposto con un «magari domani farò un salto dalla dottoressa per farmi prescrivere gli esami del sangue, forse è la stanchezza, il troppo esercizio fisico o che ne so», e tra le risate, ho terminato la chiacchierata ed anche quell’ennesima sigaretta.
Quella notte però dei dolori lancinanti mi hanno fatto spaventare. Mia moglie preoccupata mi ha consigliato che forse era il caso di andare al pronto soccorso, ma la mia testa più dura del dolore mi ha fatto aspettare, passerà ho pensato.
Non passava. Alle tre del mattino presi la macchina e feci un salto al pronto soccorso. Il tempo della strada, da casa mia l’ospedale civile di Pordenone dista solo una quindicina di chilometri e parcheggiai proprio fuori, c’erano tanti posti auto, suonai il campanello delle urgenze. Entrato in codice verde, dopo l’accettazione e le prime domande, la consueta anamnesi, feci il primo esame, quello che volevo farmi prescrivere dalla mia dottoressa: il prelievo del sangue. Passata un’oretta, nel frattempo mi fu dato anche un calmante per i dolori, forse della morfina, il dottore mi disse «Spinelli la dobbiamo ricoverare urgentemente».
Qual è stata la diagnosi
Sono rimasto 10 giorni in ospedale per accertamenti durante i quali ho fatto una Ecoendoscopia, una Colangio Risonanza Magnetica e una TAC all’addome al temine dei quali mi è stato diagnosticato un adenocarcinoma alla testa del pancreas.
Ho mandato un messaggio a mia moglie spiegandole il da farsi e raccomandandole di non preoccuparsi più di tanto: «Ho dei valori un po’ sballati nel sangue, credo; devono ricoverami per sottopormi ad altri esami. Se puoi con calma prima di iniziare a lavorare, passa e portami dentifricio e spazzolino. Ok, baci».
Mi hanno dato un letto in una stanza del pronto soccorso, accanto a me un uomo anziano stava riposando, mi sono spogliato e rilassato; ricordo di essermi fatto stupidamente anche un selfie per immortalare il momento, io in un letto di ospedale, mai in 40 anni. Sono rimasto ricoverato al pronto soccorso nel reparto di degenza breve internistica e sottoposto a molti esami, mi hanno girato e rigirato come un calzino, ma la cosa che più mi ha colpito di questo mio primo ricovero è stata la gentilezza, le parole a volte sussurrate delle infermiere, degli infermieri e del dottore, una strana gentilezza. «Che fortuna», ho pensato.
Passati un paio di giorni, mi hanno comunicato che sarei stato dimesso dal pronto soccorso perché mi avevano trovato una sistemazione in un altro reparto; sono stato accompagnato al secondo piano del Padiglione A nel reparto di Chirurgia 1 dove mi hanno assegnato una stanza.
Il codice era diventato urgente, questa volta non c’erano altri pazienti, una stanza in fondo al corridoio con bagno personale e questa volta ho pensato «caspita che culo». La mia degenza in questo reparto è stata di circa dieci giorni durante i quali, oltre ad essere sempre girato e rigirato come il famoso calzino, ho fatto molti esami tra cui un’Ecoendoscopia, una Colangio Risonanza Magnetica e una TAC all’addome; ho percepito di stare poco bene, o meglio di avere qualcosa che non andava, con il passare dei giorni e non perché ho visto dal personale infermieristico maggiori attenzioni nei miei confronti, ma perché mi sono reso conto di sostenere troppi esami, uno dietro all’altro e di scorgere nei volti dei medici che passavano per il giro visite un’espressione diversa che andava oltre i classici quesiti, «come si sente? Dolori? Dorme?».
Cercavano di suscitare in me forse una domanda cui dare subito una risposta. Volevano dirmi qualcosa, ma non erano sicuri. C’era una gran confusione nella mia testa. Ed io pensavo, non dormivo, facevo ricerche in Internet; mi sono fatto portare apposta da mia moglie tutti gli ausili tecnologici che avevo: Ipad, computer portatile, modem e un piccolo televisore, in tutte queste diavolerie cercavo aiuto, cercavo risposte, le avevo trovate, ma non volevo sapere che erano vere, avevo paura.
A fine ottobre, una mattina all’improvviso, sono stato spostato di stanza, anzi mi ricordo bene, ero andato al bagno e tornato nella mia suite ho trovato la roba personale sul letto: non mi ero sbagliato quando nel corridoio avevo intravisto un infermiere che spostava il mio comodino in un’altra stanza, con la mia roba sopra, i miei libri e i miei giornali.
Mi sono arrabbiato, ho alzato la voce, un piccolo battibecco, non aveva assolutamente colpa lui, ero io a essere nervoso più del solito, ma poi sono andato nel mio nuovo letto, nella mia nuova stanza, questa volta con un altro paziente. «Fine della pacchia» ho pensato; il mio compagno di stanza doveva essere operato per un problema di respirazione, niente di grave, ma subito mi sono sentito come sollevato, forse allora anch’io non ero così grave.
Chissà perchè alla sistemazione in camera singola avevo associato uno stadio di malattia più avanzato e, se pure mi era gradita per la maggiore libertà di cui godevo, aveva cominciato anche a preoccuparmi.
Come ti è stata comunicata la diagnosi
In questi dieci giorni non avevo fatto altro che pensare e fare ricerche su internet, avevo pensato e due più due faceva quattro, così ho giocato di anticipo: «Dottore mi scusi, ma ho il cancro?» «Purtroppo sì, mi spiace» è stata la sua risposta.
Nella mattinata i dottori facevano il giro visite, quel giorno è venuto il primario dicendomi «sa, domani la dimetteremo, ma dopo devo parlarle è importante». Eh no, a un tratto mi è venuto spontaneo, sarà stato perché non ero più in una stanza da solo, sarà stata la parola dimissioni; mi sono fatto coraggio, in questi dieci giorni non avevo fatto altro che pensare e fare ricerche su internet, avevo pensato e due più due faceva quattro, così ho giocato di anticipo: «dottore mi scusi, ma ho il cancro?» «purtroppo sì, mi spiace» è stata la sua risposta.
Il giorno dopo, l’ultimo di ottobre, nel primo pomeriggio, sono andato a casa, sicuro di aver sentito le parole più allucinanti della mia vita. Naturalmente la mia dimissione dall’ospedale precedeva un’importante operazione, quella cui si riferiva il primario nel dire «dopo le devo parlare». Sono andato a casa ancora in attesa di operazione, con ancora il mio ittero ostruttivo e con qualcosina in più, ma in discrete condizioni, così era riportato sul verbale di dimissione. Dimesso sì, perché, in effetti, c’era poco da fare, così sdraiato su di un letto di ospedale, dovevo fare quell’operazione al più presto e mi lasciarono qualche giorno per decidere in tranquillità; dovevo sapere bene a cosa andavo incontro.
Qual è stato il percorso di cura
Il 12 Novembre 2013 è stato programmato un intervento di resezione del tumore alla testa del pancreas. Durante la fase iniziale dell’intervento è stata scoperta una infiltrazione nell’arteria mesenterica superiore e quindi la diagnosi veniva aggiornata in adenocarcinoma alla testa del pancreas in stato avanzato, non operabile.
A Gennaio 2014 è cominciato il percorso con sette cicli di chemioterapia conclusosi a Luglio col protocollo che utilizzava gemcitabina e abraxane.
Poi ad Agosto 2014 mi hanno sottoposto a un mese di trattamento di 15 sedute chemio-radioterapico al CRO di Aviano in provincia di Pordenone. Certo non tutto è filato liscio nel frattempo, ho avuto problemi alle gambe che hanno comportato un lungo periodo di punture alla pancia per contrastare gli edemi, episodi di febbre alta che hanno sfiorato i 41 gradi, tanta nausea: mesi non facili. Mi hanno dovuto sostituire più volte lo stent biliare per favorire il normale deflusso della bile in duodeno: si fa con l’ERCP, colangiopancreatografia retrograda endoscopica, sino a oggi questo intervento l’ho ripetuto già tre volte.
Nell’Aprile 2015, il tumore si è ricordato della mia esistenza e mi ha mandato un salutino: ho avuto un peggioramento e ho dovuto ricominciare la chemioterapia. Per questa seconda linea di cura è stato scelto un regime chemioterapico a quattro farmaci: Folfirinox, combinazione di farmaci a base di oxaliplatino, 5-FU, leucovorina e fluorouracile.
Passato il weekend, lunedì sono stato ricevuto dal primario che mi ha spiegato nei dettagli l’operazione; delicata, complessa e a rischio non solo per le complicazioni post-operatorie cui dovevo sottopormi, per cercare di risolvere il problema, quella grana era il mio tumore al pancreas. Sarebbe durata tante ore, ma proprio tante, e mi avrebbero asportato alcuni organi e parte dello stomaco. Dovevo essere sottoposto a una duodenocefalopancreasectomia, per difficoltà tecnica è considerato l’intervento più difficile di tutta la chirurgia addominale.
Naturalmente, ho firmato quel consenso, ho avvisato mia madre di quello che sarebbe accaduto il 12 novembre e me ne sono tornato a casa con la testa al giorno undici, data del mio futuro ricovero e giorno anche del mio anniversario di matrimonio. Sì, quel giorno sarei entrato in ospedale con il pensiero che l’indomani mi sarei giocato tutto, ma anche con l’idea e la convinzione che avevo passato i 13 anni della mia vita più belli, accanto ad una donna meravigliosa, mia moglie.
Ho varcato la soglia dell’ospedale per la seconda volta sapendo che, nel bene o nel male, non sarei uscito subito. Prima mi ricordo che mi sono fumato una sigaretta, è stata l’ultima. Mi è stata assegnata una nuova suite, sempre nello stesso corridoio: quella in fondo era occupata; adesso capivo il perché della stanza singola, prima pensavo a un colpo di fortuna, adesso ero dentro la mia storia, ero cosciente di quello che avevo e della gravità della situazione. Mia madre da Catania era venuta per starmi ovviamente vicino, talmente vicino che ha pernottato in una stanza di albergo accanto all’ospedale, invece di stare in casa mia: cose da mamma.
Ero pronto.
La notte non ho chiuso occhio, l’infermiera di turno mi ha portato più di un tranquillante per prendere sonno, ma niente; sono rimasto fisso su un canale del digitale terrestre, questa volta il televisore me lo ero portato subito, facendo finta di ascoltare e pensando a milioni di cose. Mi sono preparato al grande giorno, forse potevo uscirne salvo o forse no, poco importava: sapevo che avevo solo una scelta in quel momento ed era quella giusta, ne ero convinto..
La mattina dell’operazione ho visto tutto a rallentatore, ogni preliminare mi è sembrato eterno; la salita in sala operatoria è stata come essere teletrasportati, mi sono ritrovato in un locale e non avevo riferimenti visivi esterni, sapevo solo che eravamo saliti di più piani; ricordo che ho pensato «meglio verso su che verso giù» non so perché, forse ho detto anche una battuta a chi spingeva la barella.
Mi hanno preparato, mettendomi delle calze elastiche, ricordo che l’infermiera mi ha detto che erano antitrombo, mi ha fatto ridere, ma c’era veramente poco da ridere, servivano per la prevenzione della tromboembolia venosa post operatoria. Sul letto operatorio, accanto a me, c’erano molti medici; nonostante le mascherine, ho riconosciuto subito la dottoressa; gli altri cercavo di riconoscerli dai loro occhi, erano parte dei chirurghi e il primario che a turno vedevo in reparto la sera e durante il giro visite. Li sentivo parlare, mi hanno rincuorato, erano tranquilli, loro.
Io un po’ meno, ma è passata subito. Ricordo che quella serenità mi ha aiutato molto. Poi è arrivato l’anestetista che con parole confortanti mi ha messo la maschera di ossigeno, qualche ago in vena e mi ha addormentato.
L’operazione è stata fatta naturalmente sotto anestesia totale e respirazione assistita, l’ultimo ricordo è stato l’orologio della sala operatoria. Una volta sveglio, la prima visione è stata di nuovo l’orologio della sala operatoria: era durata meno di quello che doveva essere. Poi le parole in lontananza, come sottovoce, del primario che mi ha guardato e mi ha detto «mi spiace, non ci siamo riusciti» o una frase del genere. Poi il nulla, in pochissimi secondi ho capito che qualcosa era andato storto, o meglio l’operazione non si era svolta completamente, non erano passate 6 ore.
Non sentivo nessun dolore, mi hanno accompagnato in un’altra stanza accanto alla sala operatoria, non ricordo quanto tempo sono rimasto lì dentro, ma ricordo molto bene il rientro nella mia stanza, il volto di mia moglie, di mia madre, di Dario uno dei miei cugini e di Carmelo mio amico da sempre. Passato un po’ di tempo e ho realizzato di tenere sul viso una maschera di ossigeno, vedevo cavi ovunque e tubicini, sentivo pizzicare nelle parti basse e una rigidezza nella zona addominale, ma ovviamente non sentivo al momento nessun dolore; mi è venuto spontaneo però sorridere, questo me l’ha raccontato mia moglie.
In quei giorni post operazione, ho fatto capire a mia moglie che volevo che mi fotografasse con il telefonino, che mi doveva mostrare la parte dove avevo subito l’operazione: volevo sbirciare come ero, in che condizioni. Vista la ferita per tutto il lato orizzontale del mio addome e tutti quei punti di sutura (che sembravano graffette metalliche, quelle che si usano per le scartoffie, ben fatta) sembrava tutto regolare.
Ricordo che ho pensato «credevo peggio». Il primario, mi ha spiegò bene cosa era successo e di come l’operazione dal nome lunghissimo, si era trasformata in una laparotomia esplorativa, «tutto come da protocollo» mi ha detto. Dopo l’incisione chirurgica mi hanno esplorato l’intero addome con particolare riguardo alla ricerca di eventuali micro metastasi. Il secondo passo, sempre secondo il protocollo prevedeva di confermare o meno l’asportazione della massa e a tal proposito hanno proceduto alla mobilizzazione del duodeno e della testa pancreatica per ricercare eventuali infiltrazioni nell’arteria e/o nella vena mesenterica superiore da parte del tumore. Ecco l’intoppo: l’infiltrazione, che non doveva esserci. L’equipe medica ha asportato del materiale per le biopsie e per essere sicuri del verdetto al 100%.
Da qui ha inizio la seconda parte della mia storia, da questa infiltrazione; in una frase di dieci parole si racchiude ora la mia vita e questa accompagna i referti di ogni esame che faccio o altro: adenocarcinoma alla testa del pancreas in stato avanzato, non operabile. Punto.
Sono rimasto in ospedale fino al 15 dicembre, un tempo infinito.
Primo gennaio del 2014: comincia un nuovo anno, è il compleanno di mia madre, ed io il giorno dopo inizio la mia prima esperienza in Oncologia Medica, il mio primo periodo in un nuovo reparto. Ho cambiato padiglione, ma non ospedale; adesso il Padiglione B deve ospitare me e il mio cancro. La prima impressione del reparto di oncologia al secondo piano è stata buona; mi ricordo le presentazioni di rito con il primario, con la capo sala, simpatica e disponibile. Mi è stato assegnato un numero progressivo, un numero di cartella che da quel giorno mi ha identificato come malato oncologico a tutti gli effetti e un apposito cartellino ha attestato la mia triste posizione; su quel pezzo di carta andavano annotate le date delle sedute di chemioterapia.
Ero spaventato, ma passò il primo mese ed ho messo il primo anello al dito. Non so per quale strano motivo e seguendo quale rituale, ma gli anelli sono aumentati mese dopo mese. Oggi nelle mie mani, oltre la fede, se ne possono contare sedici, come i mesi di terapia che ho superato fino ad oggi.
Esattamente il mio primo periodo di terapia si è svolto così: da gennaio a luglio con un trattamento col protocollo che utilizzava i farmaci gemcitabina e abraxane, sette cicli in totale; poi ad agosto mi hanno sottoposto a un mese di trattamento chemio-radioterapico al Cro (Centro di Riferimento Oncologico) di Aviano in provincia di Pordenone: 15 sedute, hanno voluto provare a sferrare un bel colpo al tumore perché ero riuscito a superare bene il primo periodo senza particolari problemi.
Certo non tutto è filato liscio nel frattempo, ho avuto problemi alle gambe che hanno comportato un lungo periodo di punture alla pancia per contrastare gli edemi, episodi di febbre alta che hanno sfiorato i 41 gradi, tanta nausea: mesi non facili. Mi hanno dovuto sostituire più volte lo stent biliare (una protesi tubolare in plastica o metallica) messo in chirurgia, per favorire il normale deflusso della bile in duodeno: si fa con l’ERCP (colangiopancreatografia retrograda endoscopica); sino a oggi questo intervento l’ho ripetuto già tre volte.
A intervalli regolari sono stato sottoposto a esami diagnostici particolari quali TAC (tomografia assiale computerizzata) e PET (tomografia a emissione di positroni), entrambe con mezzi di contrasto per fotografare bene la situazione: ogni volta per vedere eventuali movimenti o speranzose regressioni che possono cambiare la situazione e modificare quella fastidiosa frase «non-operabile», parole che ogni volta che mi guardo l’addome e la lunga cicatrice, con oltre 50 punti di sutura, mi sembrano assurde, sembra che ho giocato fino ad ora. Forse era meglio l’etichetta «non-rioperabile». Mi sono sottoposto anche ad altri esami, come ecografia cardiaca, scintigrafia polmonare, ecodoppler venosa agli arti inferiori, Angio TAC ai vasi addominali ed ecografie all’addome.
I giorni passavano, naturalmente dovevo fare i check-up con esami del sangue specifici e periodicamente sempre TAC e PET per vedere eventuali movimenti del tumore. Dopo una TAC, ad aprile del 2015, il mio tumore si è ricordato della mia esistenza e mi ha mandato un salutino: ho avuto un peggioramento e dovevo ricominciare la chemioterapia, sono stato ricoverato in chirurgia per l’inserimento di un port, una sorta di valvola da dove si possono somministrare i medicinali chemioterapici (le vene oramai deboli del mio corpo non consentivano più nuove iniezioni) ed è iniziato un secondo periodo di terapia.
Questa volta non potendo rifare il precedente trattamento, il mio oncologo ha scelto un protocollo con maggiore tossicità, ma a suo dire più efficace, in grado di rallentare la progressione del male rispetto anche al trattamento standard. Dovevo urgentemente iniziare un regime chemioterapico a quattro farmaci (oxaliplatino, irinotecan, leucovorina e fluorouracile) folfirinox; naturalmente con il mio consenso ed ho iniziato questa nuova avventura, con la speranza di mettere il bastone tra le ruote al tumore.
Una terapia diversa, con effetti collaterali forti, ho ricevuto tutte le informazioni in merito: il protocollo prevedeva che uno di questi farmaci, l’irinotecan fotosensibile – quindi da tenere al riparo dalla luce – dovesse essere somministrato nell’arco delle 48 ore, quindi oltre alle 5-6 ore di seduta mi portavo a casa take-away la bottiglietta con all’interno quel medicinale: c’era un palloncino che man mano si andava sgonfiando e rilasciava l’infusione nelle mie vene. Era dura, questo giro la vedevo dura.
E cosi è stato. A differenza della precedente chemioterapia ho accusato il colpo, ma mai, dico mai, ho mollato; seguito passo passo dai dottori sono riuscito a metter altri otto anelli alle mie dita. I controlli hanno confermato che il cancro si era stabilizzato e che non avanzava per adesso, pur rimanendo non operabile. Così sono arrivato fino a novembre del 2015 ed ho terminato la terapia; da allora non posso fare più nulla se non tenerlo a bada, fotografarlo a intervalli regolari.
Oggi a distanza di più di 4 anni cosa ci puoi dire
Da quel novembre del 2015 sono entrato in una situazione di equilibrio come un aereo nel momento prima dello stallo, mi viene detto che non è possibile andare oltre, che non si può fare più nulla, che bisogna solo sottoporsi ai controlli periodici e sopravvivere con questo grave tumore. Ho trovato il modo di reagire camminando, questo antico modo di muoversi mi fa star bene e diventa il mio modo di ringraziare la vita nonostante tutto. Ho iniziato con il recarmi in ospedale a piedi da casa mia che dista circa quindici chilometri per poi fare piccole escursioni in montagna fino ad iniziare dei veri e propri cammini. Dal confine Italo-Austriaco di Tarvisio ho percorso a piedi tanta strada, ho valicato l’Appenino Emiliano dal passo di Croce Arcana per arrivare fino a Fucecchio in Toscana, calcando le orme degli antichi pellegrini sulla Romea Strata. Successivamente ho risalito la Via Francigena fino a Sarzana per proseguire fino al confine italo-francese seguendo la Via della Costa. Qualche passo anche in Francia per poi con un treno ho raggiunto Saint Jean Pied de Port ai piedi dei Pirenei per arrivare fino all’oceano Atlantico passando per Santiago di Compostela. In totale 2.248 chilometri percorsi a piedi.
Riporto il diario delle varie tappe del mio cammino sul mio blog, racconto anche gli stop forzati a causa dei controlli che mi ha imposto la malattia e dei “pit-stop” necessari per riprendere le forze. Intervalli e pause che “riempio” con altre escursioni nella Regione che mi ha adottato, il Friuli Venezia Giulia e non solo. Considero la fine di ogni escursione, il termine di ogni trekking, la conclusione di ogni cammino come punto d’inizio per altre mete e non come punto di arrivo. Vivere e sopravvivere con questo fastidioso compagno di viaggio, “se di cancro si muore pur si vive” è il mio motto. Se questo raccontare “il cammino con il cancro” può essere di aiuto anche ad una sola persona, allora alla fine non avrò perso, ma avrò vinto.
E se proprio devo dare i numeri: giorno dopo giorno e passo dopo passo, i chilometri aumentano (ad oggi ho percorso più di 6000km) e anche i giorni che ho la fortuna di vedere in questo mondo aumentano (ho 44 anni e sono nel quinto anno dalla diagnosi della mia malattia). Che altro dire? Buona vita!
Il blog di Andrea Spinelli è: andreaspinelli.it
Recentemente Andrea ha pubblicato un suo libro “Se cammino vivo. Se di cammino si muore pur vive” dove racconta il modo con cui convive con il tumore e combatte lo stigma sociale che aleggia intorno a questa malattia. Il libro è disponibile al seguente indirizzo:
Condividi questo articolo

Andrea Spinelli, 44 anni, da più di quattro anni convive con un tumore al pancreas non operabile. Tutte le innumerevoli difficoltà creategli da questa complessa patologia non gli hanno precluso il progetto di attraversare l’Italia e l’Europa a piedi. Il suo motto: Buona Vita a Tutti!
Come hai scoperto di avere un tumore al pancreas
17 Ottobre 2013 un amico mi fa notare il colore giallo dei miei occhi. La stessa notte mi sono venuti dei forti dolori all’addome e il mattino alle 3 decido di andare al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pordenone.
Era il 17 ottobre, sempre del 2013, tardo pomeriggio; stavo fumando una sigaretta del mio secondo pacchetto, parlavo del più e del meno con un amico, quando a un tratto mi ha fatto notare, «Sai Spino – gli amici mi chiamano con questo soprannome – hai gli occhi gialli». Al momento non ho dato tanto peso alla cosa e ho risposto con un «magari domani farò un salto dalla dottoressa per farmi prescrivere gli esami del sangue, forse è la stanchezza, il troppo esercizio fisico o che ne so», e tra le risate, ho terminato la chiacchierata ed anche quell’ennesima sigaretta.
Quella notte però dei dolori lancinanti mi hanno fatto spaventare. Mia moglie preoccupata mi ha consigliato che forse era il caso di andare al pronto soccorso, ma la mia testa più dura del dolore mi ha fatto aspettare, passerà ho pensato.
Non passava. Alle tre del mattino presi la macchina e feci un salto al pronto soccorso. Il tempo della strada, da casa mia l’ospedale civile di Pordenone dista solo una quindicina di chilometri e parcheggiai proprio fuori, c’erano tanti posti auto, suonai il campanello delle urgenze. Entrato in codice verde, dopo l’accettazione e le prime domande, la consueta anamnesi, feci il primo esame, quello che volevo farmi prescrivere dalla mia dottoressa: il prelievo del sangue. Passata un’oretta, nel frattempo mi fu dato anche un calmante per i dolori, forse della morfina, il dottore mi disse «Spinelli la dobbiamo ricoverare urgentemente».
Qual è stata la diagnosi
Sono rimasto 10 giorni in ospedale per accertamenti durante i quali ho fatto una Ecoendoscopia, una Colangio Risonanza Magnetica e una TAC all’addome al temine dei quali mi è stato diagnosticato un adenocarcinoma alla testa del pancreas.
Ho mandato un messaggio a mia moglie spiegandole il da farsi e raccomandandole di non preoccuparsi più di tanto: «Ho dei valori un po’ sballati nel sangue, credo; devono ricoverami per sottopormi ad altri esami. Se puoi con calma prima di iniziare a lavorare, passa e portami dentifricio e spazzolino. Ok, baci».
Mi hanno dato un letto in una stanza del pronto soccorso, accanto a me un uomo anziano stava riposando, mi sono spogliato e rilassato; ricordo di essermi fatto stupidamente anche un selfie per immortalare il momento, io in un letto di ospedale, mai in 40 anni. Sono rimasto ricoverato al pronto soccorso nel reparto di degenza breve internistica e sottoposto a molti esami, mi hanno girato e rigirato come un calzino, ma la cosa che più mi ha colpito di questo mio primo ricovero è stata la gentilezza, le parole a volte sussurrate delle infermiere, degli infermieri e del dottore, una strana gentilezza. «Che fortuna», ho pensato.
Passati un paio di giorni, mi hanno comunicato che sarei stato dimesso dal pronto soccorso perché mi avevano trovato una sistemazione in un altro reparto; sono stato accompagnato al secondo piano del Padiglione A nel reparto di Chirurgia 1 dove mi hanno assegnato una stanza.
Il codice era diventato urgente, questa volta non c’erano altri pazienti, una stanza in fondo al corridoio con bagno personale e questa volta ho pensato «caspita che culo». La mia degenza in questo reparto è stata di circa dieci giorni durante i quali, oltre ad essere sempre girato e rigirato come il famoso calzino, ho fatto molti esami tra cui un’Ecoendoscopia, una Colangio Risonanza Magnetica e una TAC all’addome; ho percepito di stare poco bene, o meglio di avere qualcosa che non andava, con il passare dei giorni e non perché ho visto dal personale infermieristico maggiori attenzioni nei miei confronti, ma perché mi sono reso conto di sostenere troppi esami, uno dietro all’altro e di scorgere nei volti dei medici che passavano per il giro visite un’espressione diversa che andava oltre i classici quesiti, «come si sente? Dolori? Dorme?».
Cercavano di suscitare in me forse una domanda cui dare subito una risposta. Volevano dirmi qualcosa, ma non erano sicuri. C’era una gran confusione nella mia testa. Ed io pensavo, non dormivo, facevo ricerche in Internet; mi sono fatto portare apposta da mia moglie tutti gli ausili tecnologici che avevo: Ipad, computer portatile, modem e un piccolo televisore, in tutte queste diavolerie cercavo aiuto, cercavo risposte, le avevo trovate, ma non volevo sapere che erano vere, avevo paura.
A fine ottobre, una mattina all’improvviso, sono stato spostato di stanza, anzi mi ricordo bene, ero andato al bagno e tornato nella mia suite ho trovato la roba personale sul letto: non mi ero sbagliato quando nel corridoio avevo intravisto un infermiere che spostava il mio comodino in un’altra stanza, con la mia roba sopra, i miei libri e i miei giornali.
Mi sono arrabbiato, ho alzato la voce, un piccolo battibecco, non aveva assolutamente colpa lui, ero io a essere nervoso più del solito, ma poi sono andato nel mio nuovo letto, nella mia nuova stanza, questa volta con un altro paziente. «Fine della pacchia» ho pensato; il mio compagno di stanza doveva essere operato per un problema di respirazione, niente di grave, ma subito mi sono sentito come sollevato, forse allora anch’io non ero così grave.
Chissà perchè alla sistemazione in camera singola avevo associato uno stadio di malattia più avanzato e, se pure mi era gradita per la maggiore libertà di cui godevo, aveva cominciato anche a preoccuparmi.
Come ti è stata comunicata la diagnosi
In questi dieci giorni non avevo fatto altro che pensare e fare ricerche su internet, avevo pensato e due più due faceva quattro, così ho giocato di anticipo: «Dottore mi scusi, ma ho il cancro?» «Purtroppo sì, mi spiace» è stata la sua risposta.
Nella mattinata i dottori facevano il giro visite, quel giorno è venuto il primario dicendomi «sa, domani la dimetteremo, ma dopo devo parlarle è importante». Eh no, a un tratto mi è venuto spontaneo, sarà stato perché non ero più in una stanza da solo, sarà stata la parola dimissioni; mi sono fatto coraggio, in questi dieci giorni non avevo fatto altro che pensare e fare ricerche su internet, avevo pensato e due più due faceva quattro, così ho giocato di anticipo: «dottore mi scusi, ma ho il cancro?» «purtroppo sì, mi spiace» è stata la sua risposta.
Il giorno dopo, l’ultimo di ottobre, nel primo pomeriggio, sono andato a casa, sicuro di aver sentito le parole più allucinanti della mia vita. Naturalmente la mia dimissione dall’ospedale precedeva un’importante operazione, quella cui si riferiva il primario nel dire «dopo le devo parlare». Sono andato a casa ancora in attesa di operazione, con ancora il mio ittero ostruttivo e con qualcosina in più, ma in discrete condizioni, così era riportato sul verbale di dimissione. Dimesso sì, perché, in effetti, c’era poco da fare, così sdraiato su di un letto di ospedale, dovevo fare quell’operazione al più presto e mi lasciarono qualche giorno per decidere in tranquillità; dovevo sapere bene a cosa andavo incontro.
Qual è stato il percorso di cura
Il 12 Novembre 2013 è stato programmato un intervento di resezione del tumore alla testa del pancreas. Durante la fase iniziale dell’intervento è stata scoperta una infiltrazione nell’arteria mesenterica superiore e quindi la diagnosi veniva aggiornata in adenocarcinoma alla testa del pancreas in stato avanzato, non operabile.
A Gennaio 2014 è cominciato il percorso con sette cicli di chemioterapia conclusosi a Luglio col protocollo che utilizzava gemcitabina e abraxane.
Poi ad Agosto 2014 mi hanno sottoposto a un mese di trattamento di 15 sedute chemio-radioterapico al CRO di Aviano in provincia di Pordenone. Certo non tutto è filato liscio nel frattempo, ho avuto problemi alle gambe che hanno comportato un lungo periodo di punture alla pancia per contrastare gli edemi, episodi di febbre alta che hanno sfiorato i 41 gradi, tanta nausea: mesi non facili. Mi hanno dovuto sostituire più volte lo stent biliare per favorire il normale deflusso della bile in duodeno: si fa con l’ERCP, colangiopancreatografia retrograda endoscopica, sino a oggi questo intervento l’ho ripetuto già tre volte.
Nell’Aprile 2015, il tumore si è ricordato della mia esistenza e mi ha mandato un salutino: ho avuto un peggioramento e ho dovuto ricominciare la chemioterapia. Per questa seconda linea di cura è stato scelto un regime chemioterapico a quattro farmaci: Folfirinox, combinazione di farmaci a base di oxaliplatino, 5-FU, leucovorina e fluorouracile.
Passato il weekend, lunedì sono stato ricevuto dal primario che mi ha spiegato nei dettagli l’operazione; delicata, complessa e a rischio non solo per le complicazioni post-operatorie cui dovevo sottopormi, per cercare di risolvere il problema, quella grana era il mio tumore al pancreas. Sarebbe durata tante ore, ma proprio tante, e mi avrebbero asportato alcuni organi e parte dello stomaco. Dovevo essere sottoposto a una duodenocefalopancreasectomia, per difficoltà tecnica è considerato l’intervento più difficile di tutta la chirurgia addominale.
Naturalmente, ho firmato quel consenso, ho avvisato mia madre di quello che sarebbe accaduto il 12 novembre e me ne sono tornato a casa con la testa al giorno undici, data del mio futuro ricovero e giorno anche del mio anniversario di matrimonio. Sì, quel giorno sarei entrato in ospedale con il pensiero che l’indomani mi sarei giocato tutto, ma anche con l’idea e la convinzione che avevo passato i 13 anni della mia vita più belli, accanto ad una donna meravigliosa, mia moglie.
Ho varcato la soglia dell’ospedale per la seconda volta sapendo che, nel bene o nel male, non sarei uscito subito. Prima mi ricordo che mi sono fumato una sigaretta, è stata l’ultima. Mi è stata assegnata una nuova suite, sempre nello stesso corridoio: quella in fondo era occupata; adesso capivo il perché della stanza singola, prima pensavo a un colpo di fortuna, adesso ero dentro la mia storia, ero cosciente di quello che avevo e della gravità della situazione. Mia madre da Catania era venuta per starmi ovviamente vicino, talmente vicino che ha pernottato in una stanza di albergo accanto all’ospedale, invece di stare in casa mia: cose da mamma.
Ero pronto.
La notte non ho chiuso occhio, l’infermiera di turno mi ha portato più di un tranquillante per prendere sonno, ma niente; sono rimasto fisso su un canale del digitale terrestre, questa volta il televisore me lo ero portato subito, facendo finta di ascoltare e pensando a milioni di cose. Mi sono preparato al grande giorno, forse potevo uscirne salvo o forse no, poco importava: sapevo che avevo solo una scelta in quel momento ed era quella giusta, ne ero convinto..
La mattina dell’operazione ho visto tutto a rallentatore, ogni preliminare mi è sembrato eterno; la salita in sala operatoria è stata come essere teletrasportati, mi sono ritrovato in un locale e non avevo riferimenti visivi esterni, sapevo solo che eravamo saliti di più piani; ricordo che ho pensato «meglio verso su che verso giù» non so perché, forse ho detto anche una battuta a chi spingeva la barella.
Mi hanno preparato, mettendomi delle calze elastiche, ricordo che l’infermiera mi ha detto che erano antitrombo, mi ha fatto ridere, ma c’era veramente poco da ridere, servivano per la prevenzione della tromboembolia venosa post operatoria. Sul letto operatorio, accanto a me, c’erano molti medici; nonostante le mascherine, ho riconosciuto subito la dottoressa; gli altri cercavo di riconoscerli dai loro occhi, erano parte dei chirurghi e il primario che a turno vedevo in reparto la sera e durante il giro visite. Li sentivo parlare, mi hanno rincuorato, erano tranquilli, loro.
Io un po’ meno, ma è passata subito. Ricordo che quella serenità mi ha aiutato molto. Poi è arrivato l’anestetista che con parole confortanti mi ha messo la maschera di ossigeno, qualche ago in vena e mi ha addormentato.
L’operazione è stata fatta naturalmente sotto anestesia totale e respirazione assistita, l’ultimo ricordo è stato l’orologio della sala operatoria. Una volta sveglio, la prima visione è stata di nuovo l’orologio della sala operatoria: era durata meno di quello che doveva essere. Poi le parole in lontananza, come sottovoce, del primario che mi ha guardato e mi ha detto «mi spiace, non ci siamo riusciti» o una frase del genere. Poi il nulla, in pochissimi secondi ho capito che qualcosa era andato storto, o meglio l’operazione non si era svolta completamente, non erano passate 6 ore.
Non sentivo nessun dolore, mi hanno accompagnato in un’altra stanza accanto alla sala operatoria, non ricordo quanto tempo sono rimasto lì dentro, ma ricordo molto bene il rientro nella mia stanza, il volto di mia moglie, di mia madre, di Dario uno dei miei cugini e di Carmelo mio amico da sempre. Passato un po’ di tempo e ho realizzato di tenere sul viso una maschera di ossigeno, vedevo cavi ovunque e tubicini, sentivo pizzicare nelle parti basse e una rigidezza nella zona addominale, ma ovviamente non sentivo al momento nessun dolore; mi è venuto spontaneo però sorridere, questo me l’ha raccontato mia moglie.
In quei giorni post operazione, ho fatto capire a mia moglie che volevo che mi fotografasse con il telefonino, che mi doveva mostrare la parte dove avevo subito l’operazione: volevo sbirciare come ero, in che condizioni. Vista la ferita per tutto il lato orizzontale del mio addome e tutti quei punti di sutura (che sembravano graffette metalliche, quelle che si usano per le scartoffie, ben fatta) sembrava tutto regolare.
Ricordo che ho pensato «credevo peggio». Il primario, mi ha spiegò bene cosa era successo e di come l’operazione dal nome lunghissimo, si era trasformata in una laparotomia esplorativa, «tutto come da protocollo» mi ha detto. Dopo l’incisione chirurgica mi hanno esplorato l’intero addome con particolare riguardo alla ricerca di eventuali micro metastasi. Il secondo passo, sempre secondo il protocollo prevedeva di confermare o meno l’asportazione della massa e a tal proposito hanno proceduto alla mobilizzazione del duodeno e della testa pancreatica per ricercare eventuali infiltrazioni nell’arteria e/o nella vena mesenterica superiore da parte del tumore. Ecco l’intoppo: l’infiltrazione, che non doveva esserci. L’equipe medica ha asportato del materiale per le biopsie e per essere sicuri del verdetto al 100%.
Da qui ha inizio la seconda parte della mia storia, da questa infiltrazione; in una frase di dieci parole si racchiude ora la mia vita e questa accompagna i referti di ogni esame che faccio o altro: adenocarcinoma alla testa del pancreas in stato avanzato, non operabile. Punto.
Sono rimasto in ospedale fino al 15 dicembre, un tempo infinito.
Primo gennaio del 2014: comincia un nuovo anno, è il compleanno di mia madre, ed io il giorno dopo inizio la mia prima esperienza in Oncologia Medica, il mio primo periodo in un nuovo reparto. Ho cambiato padiglione, ma non ospedale; adesso il Padiglione B deve ospitare me e il mio cancro. La prima impressione del reparto di oncologia al secondo piano è stata buona; mi ricordo le presentazioni di rito con il primario, con la capo sala, simpatica e disponibile. Mi è stato assegnato un numero progressivo, un numero di cartella che da quel giorno mi ha identificato come malato oncologico a tutti gli effetti e un apposito cartellino ha attestato la mia triste posizione; su quel pezzo di carta andavano annotate le date delle sedute di chemioterapia.
Ero spaventato, ma passò il primo mese ed ho messo il primo anello al dito. Non so per quale strano motivo e seguendo quale rituale, ma gli anelli sono aumentati mese dopo mese. Oggi nelle mie mani, oltre la fede, se ne possono contare sedici, come i mesi di terapia che ho superato fino ad oggi.
Esattamente il mio primo periodo di terapia si è svolto così: da gennaio a luglio con un trattamento col protocollo che utilizzava i farmaci gemcitabina e abraxane, sette cicli in totale; poi ad agosto mi hanno sottoposto a un mese di trattamento chemio-radioterapico al Cro (Centro di Riferimento Oncologico) di Aviano in provincia di Pordenone: 15 sedute, hanno voluto provare a sferrare un bel colpo al tumore perché ero riuscito a superare bene il primo periodo senza particolari problemi.
Certo non tutto è filato liscio nel frattempo, ho avuto problemi alle gambe che hanno comportato un lungo periodo di punture alla pancia per contrastare gli edemi, episodi di febbre alta che hanno sfiorato i 41 gradi, tanta nausea: mesi non facili. Mi hanno dovuto sostituire più volte lo stent biliare (una protesi tubolare in plastica o metallica) messo in chirurgia, per favorire il normale deflusso della bile in duodeno: si fa con l’ERCP (colangiopancreatografia retrograda endoscopica); sino a oggi questo intervento l’ho ripetuto già tre volte.
A intervalli regolari sono stato sottoposto a esami diagnostici particolari quali TAC (tomografia assiale computerizzata) e PET (tomografia a emissione di positroni), entrambe con mezzi di contrasto per fotografare bene la situazione: ogni volta per vedere eventuali movimenti o speranzose regressioni che possono cambiare la situazione e modificare quella fastidiosa frase «non-operabile», parole che ogni volta che mi guardo l’addome e la lunga cicatrice, con oltre 50 punti di sutura, mi sembrano assurde, sembra che ho giocato fino ad ora. Forse era meglio l’etichetta «non-rioperabile». Mi sono sottoposto anche ad altri esami, come ecografia cardiaca, scintigrafia polmonare, ecodoppler venosa agli arti inferiori, Angio TAC ai vasi addominali ed ecografie all’addome.
I giorni passavano, naturalmente dovevo fare i check-up con esami del sangue specifici e periodicamente sempre TAC e PET per vedere eventuali movimenti del tumore. Dopo una TAC, ad aprile del 2015, il mio tumore si è ricordato della mia esistenza e mi ha mandato un salutino: ho avuto un peggioramento e dovevo ricominciare la chemioterapia, sono stato ricoverato in chirurgia per l’inserimento di un port, una sorta di valvola da dove si possono somministrare i medicinali chemioterapici (le vene oramai deboli del mio corpo non consentivano più nuove iniezioni) ed è iniziato un secondo periodo di terapia.
Questa volta non potendo rifare il precedente trattamento, il mio oncologo ha scelto un protocollo con maggiore tossicità, ma a suo dire più efficace, in grado di rallentare la progressione del male rispetto anche al trattamento standard. Dovevo urgentemente iniziare un regime chemioterapico a quattro farmaci (oxaliplatino, irinotecan, leucovorina e fluorouracile) folfirinox; naturalmente con il mio consenso ed ho iniziato questa nuova avventura, con la speranza di mettere il bastone tra le ruote al tumore.
Una terapia diversa, con effetti collaterali forti, ho ricevuto tutte le informazioni in merito: il protocollo prevedeva che uno di questi farmaci, l’irinotecan fotosensibile – quindi da tenere al riparo dalla luce – dovesse essere somministrato nell’arco delle 48 ore, quindi oltre alle 5-6 ore di seduta mi portavo a casa take-away la bottiglietta con all’interno quel medicinale: c’era un palloncino che man mano si andava sgonfiando e rilasciava l’infusione nelle mie vene. Era dura, questo giro la vedevo dura.
E cosi è stato. A differenza della precedente chemioterapia ho accusato il colpo, ma mai, dico mai, ho mollato; seguito passo passo dai dottori sono riuscito a metter altri otto anelli alle mie dita. I controlli hanno confermato che il cancro si era stabilizzato e che non avanzava per adesso, pur rimanendo non operabile. Così sono arrivato fino a novembre del 2015 ed ho terminato la terapia; da allora non posso fare più nulla se non tenerlo a bada, fotografarlo a intervalli regolari.
Oggi a distanza di più di 4 anni cosa ci puoi dire
Da quel novembre del 2015 sono entrato in una situazione di equilibrio come un aereo nel momento prima dello stallo, mi viene detto che non è possibile andare oltre, che non si può fare più nulla, che bisogna solo sottoporsi ai controlli periodici e sopravvivere con questo grave tumore. Ho trovato il modo di reagire camminando, questo antico modo di muoversi mi fa star bene e diventa il mio modo di ringraziare la vita nonostante tutto. Ho iniziato con il recarmi in ospedale a piedi da casa mia che dista circa quindici chilometri per poi fare piccole escursioni in montagna fino ad iniziare dei veri e propri cammini. Dal confine Italo-Austriaco di Tarvisio ho percorso a piedi tanta strada, ho valicato l’Appenino Emiliano dal passo di Croce Arcana per arrivare fino a Fucecchio in Toscana, calcando le orme degli antichi pellegrini sulla Romea Strata. Successivamente ho risalito la Via Francigena fino a Sarzana per proseguire fino al confine italo-francese seguendo la Via della Costa. Qualche passo anche in Francia per poi con un treno ho raggiunto Saint Jean Pied de Port ai piedi dei Pirenei per arrivare fino all’oceano Atlantico passando per Santiago di Compostela. In totale 2.248 chilometri percorsi a piedi.
Riporto il diario delle varie tappe del mio cammino sul mio blog, racconto anche gli stop forzati a causa dei controlli che mi ha imposto la malattia e dei “pit-stop” necessari per riprendere le forze. Intervalli e pause che “riempio” con altre escursioni nella Regione che mi ha adottato, il Friuli Venezia Giulia e non solo. Considero la fine di ogni escursione, il termine di ogni trekking, la conclusione di ogni cammino come punto d’inizio per altre mete e non come punto di arrivo. Vivere e sopravvivere con questo fastidioso compagno di viaggio, “se di cancro si muore pur si vive” è il mio motto. Se questo raccontare “il cammino con il cancro” può essere di aiuto anche ad una sola persona, allora alla fine non avrò perso, ma avrò vinto.
E se proprio devo dare i numeri: giorno dopo giorno e passo dopo passo, i chilometri aumentano (ad oggi ho percorso più di 6000km) e anche i giorni che ho la fortuna di vedere in questo mondo aumentano (ho 44 anni e sono nel quinto anno dalla diagnosi della mia malattia). Che altro dire? Buona vita!
Il blog di Andrea Spinelli è: andreaspinelli.it
Recentemente Andrea ha pubblicato un suo libro “Se cammino vivo. Se di cammino si muore pur vive” dove racconta il modo con cui convive con il tumore e combatte lo stigma sociale che aleggia intorno a questa malattia. Il libro è disponibile al seguente indirizzo:
Condividi questo articolo

Andrea Spinelli, 44 anni, da più di quattro anni convive con un tumore al pancreas non operabile. Tutte le innumerevoli difficoltà creategli da questa complessa patologia non gli hanno precluso il progetto di attraversare l’Italia e l’Europa a piedi. Il suo motto: Buona Vita a Tutti!
Come hai scoperto di avere un tumore al pancreas
17 Ottobre 2013 un amico mi fa notare il colore giallo dei miei occhi. La stessa notte mi sono venuti dei forti dolori all’addome e il mattino alle 3 decido di andare al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pordenone.
Era il 17 ottobre, sempre del 2013, tardo pomeriggio; stavo fumando una sigaretta del mio secondo pacchetto, parlavo del più e del meno con un amico, quando a un tratto mi ha fatto notare, «Sai Spino – gli amici mi chiamano con questo soprannome – hai gli occhi gialli». Al momento non ho dato tanto peso alla cosa e ho risposto con un «magari domani farò un salto dalla dottoressa per farmi prescrivere gli esami del sangue, forse è la stanchezza, il troppo esercizio fisico o che ne so», e tra le risate, ho terminato la chiacchierata ed anche quell’ennesima sigaretta.
Quella notte però dei dolori lancinanti mi hanno fatto spaventare. Mia moglie preoccupata mi ha consigliato che forse era il caso di andare al pronto soccorso, ma la mia testa più dura del dolore mi ha fatto aspettare, passerà ho pensato.
Non passava. Alle tre del mattino presi la macchina e feci un salto al pronto soccorso. Il tempo della strada, da casa mia l’ospedale civile di Pordenone dista solo una quindicina di chilometri e parcheggiai proprio fuori, c’erano tanti posti auto, suonai il campanello delle urgenze. Entrato in codice verde, dopo l’accettazione e le prime domande, la consueta anamnesi, feci il primo esame, quello che volevo farmi prescrivere dalla mia dottoressa: il prelievo del sangue. Passata un’oretta, nel frattempo mi fu dato anche un calmante per i dolori, forse della morfina, il dottore mi disse «Spinelli la dobbiamo ricoverare urgentemente».
Qual è stata la diagnosi
Sono rimasto 10 giorni in ospedale per accertamenti durante i quali ho fatto una Ecoendoscopia, una Colangio Risonanza Magnetica e una TAC all’addome al temine dei quali mi è stato diagnosticato un adenocarcinoma alla testa del pancreas.
Ho mandato un messaggio a mia moglie spiegandole il da farsi e raccomandandole di non preoccuparsi più di tanto: «Ho dei valori un po’ sballati nel sangue, credo; devono ricoverami per sottopormi ad altri esami. Se puoi con calma prima di iniziare a lavorare, passa e portami dentifricio e spazzolino. Ok, baci».
Mi hanno dato un letto in una stanza del pronto soccorso, accanto a me un uomo anziano stava riposando, mi sono spogliato e rilassato; ricordo di essermi fatto stupidamente anche un selfie per immortalare il momento, io in un letto di ospedale, mai in 40 anni. Sono rimasto ricoverato al pronto soccorso nel reparto di degenza breve internistica e sottoposto a molti esami, mi hanno girato e rigirato come un calzino, ma la cosa che più mi ha colpito di questo mio primo ricovero è stata la gentilezza, le parole a volte sussurrate delle infermiere, degli infermieri e del dottore, una strana gentilezza. «Che fortuna», ho pensato.
Passati un paio di giorni, mi hanno comunicato che sarei stato dimesso dal pronto soccorso perché mi avevano trovato una sistemazione in un altro reparto; sono stato accompagnato al secondo piano del Padiglione A nel reparto di Chirurgia 1 dove mi hanno assegnato una stanza.
Il codice era diventato urgente, questa volta non c’erano altri pazienti, una stanza in fondo al corridoio con bagno personale e questa volta ho pensato «caspita che culo». La mia degenza in questo reparto è stata di circa dieci giorni durante i quali, oltre ad essere sempre girato e rigirato come il famoso calzino, ho fatto molti esami tra cui un’Ecoendoscopia, una Colangio Risonanza Magnetica e una TAC all’addome; ho percepito di stare poco bene, o meglio di avere qualcosa che non andava, con il passare dei giorni e non perché ho visto dal personale infermieristico maggiori attenzioni nei miei confronti, ma perché mi sono reso conto di sostenere troppi esami, uno dietro all’altro e di scorgere nei volti dei medici che passavano per il giro visite un’espressione diversa che andava oltre i classici quesiti, «come si sente? Dolori? Dorme?».
Cercavano di suscitare in me forse una domanda cui dare subito una risposta. Volevano dirmi qualcosa, ma non erano sicuri. C’era una gran confusione nella mia testa. Ed io pensavo, non dormivo, facevo ricerche in Internet; mi sono fatto portare apposta da mia moglie tutti gli ausili tecnologici che avevo: Ipad, computer portatile, modem e un piccolo televisore, in tutte queste diavolerie cercavo aiuto, cercavo risposte, le avevo trovate, ma non volevo sapere che erano vere, avevo paura.
A fine ottobre, una mattina all’improvviso, sono stato spostato di stanza, anzi mi ricordo bene, ero andato al bagno e tornato nella mia suite ho trovato la roba personale sul letto: non mi ero sbagliato quando nel corridoio avevo intravisto un infermiere che spostava il mio comodino in un’altra stanza, con la mia roba sopra, i miei libri e i miei giornali.
Mi sono arrabbiato, ho alzato la voce, un piccolo battibecco, non aveva assolutamente colpa lui, ero io a essere nervoso più del solito, ma poi sono andato nel mio nuovo letto, nella mia nuova stanza, questa volta con un altro paziente. «Fine della pacchia» ho pensato; il mio compagno di stanza doveva essere operato per un problema di respirazione, niente di grave, ma subito mi sono sentito come sollevato, forse allora anch’io non ero così grave.
Chissà perchè alla sistemazione in camera singola avevo associato uno stadio di malattia più avanzato e, se pure mi era gradita per la maggiore libertà di cui godevo, aveva cominciato anche a preoccuparmi.
Come ti è stata comunicata la diagnosi
In questi dieci giorni non avevo fatto altro che pensare e fare ricerche su internet, avevo pensato e due più due faceva quattro, così ho giocato di anticipo: «Dottore mi scusi, ma ho il cancro?» «Purtroppo sì, mi spiace» è stata la sua risposta.
Nella mattinata i dottori facevano il giro visite, quel giorno è venuto il primario dicendomi «sa, domani la dimetteremo, ma dopo devo parlarle è importante». Eh no, a un tratto mi è venuto spontaneo, sarà stato perché non ero più in una stanza da solo, sarà stata la parola dimissioni; mi sono fatto coraggio, in questi dieci giorni non avevo fatto altro che pensare e fare ricerche su internet, avevo pensato e due più due faceva quattro, così ho giocato di anticipo: «dottore mi scusi, ma ho il cancro?» «purtroppo sì, mi spiace» è stata la sua risposta.
Il giorno dopo, l’ultimo di ottobre, nel primo pomeriggio, sono andato a casa, sicuro di aver sentito le parole più allucinanti della mia vita. Naturalmente la mia dimissione dall’ospedale precedeva un’importante operazione, quella cui si riferiva il primario nel dire «dopo le devo parlare». Sono andato a casa ancora in attesa di operazione, con ancora il mio ittero ostruttivo e con qualcosina in più, ma in discrete condizioni, così era riportato sul verbale di dimissione. Dimesso sì, perché, in effetti, c’era poco da fare, così sdraiato su di un letto di ospedale, dovevo fare quell’operazione al più presto e mi lasciarono qualche giorno per decidere in tranquillità; dovevo sapere bene a cosa andavo incontro.
Qual è stato il percorso di cura
Il 12 Novembre 2013 è stato programmato un intervento di resezione del tumore alla testa del pancreas. Durante la fase iniziale dell’intervento è stata scoperta una infiltrazione nell’arteria mesenterica superiore e quindi la diagnosi veniva aggiornata in adenocarcinoma alla testa del pancreas in stato avanzato, non operabile.
A Gennaio 2014 è cominciato il percorso con sette cicli di chemioterapia conclusosi a Luglio col protocollo che utilizzava gemcitabina e abraxane.
Poi ad Agosto 2014 mi hanno sottoposto a un mese di trattamento di 15 sedute chemio-radioterapico al CRO di Aviano in provincia di Pordenone. Certo non tutto è filato liscio nel frattempo, ho avuto problemi alle gambe che hanno comportato un lungo periodo di punture alla pancia per contrastare gli edemi, episodi di febbre alta che hanno sfiorato i 41 gradi, tanta nausea: mesi non facili. Mi hanno dovuto sostituire più volte lo stent biliare per favorire il normale deflusso della bile in duodeno: si fa con l’ERCP, colangiopancreatografia retrograda endoscopica, sino a oggi questo intervento l’ho ripetuto già tre volte.
Nell’Aprile 2015, il tumore si è ricordato della mia esistenza e mi ha mandato un salutino: ho avuto un peggioramento e ho dovuto ricominciare la chemioterapia. Per questa seconda linea di cura è stato scelto un regime chemioterapico a quattro farmaci: Folfirinox, combinazione di farmaci a base di oxaliplatino, 5-FU, leucovorina e fluorouracile.
Passato il weekend, lunedì sono stato ricevuto dal primario che mi ha spiegato nei dettagli l’operazione; delicata, complessa e a rischio non solo per le complicazioni post-operatorie cui dovevo sottopormi, per cercare di risolvere il problema, quella grana era il mio tumore al pancreas. Sarebbe durata tante ore, ma proprio tante, e mi avrebbero asportato alcuni organi e parte dello stomaco. Dovevo essere sottoposto a una duodenocefalopancreasectomia, per difficoltà tecnica è considerato l’intervento più difficile di tutta la chirurgia addominale.
Naturalmente, ho firmato quel consenso, ho avvisato mia madre di quello che sarebbe accaduto il 12 novembre e me ne sono tornato a casa con la testa al giorno undici, data del mio futuro ricovero e giorno anche del mio anniversario di matrimonio. Sì, quel giorno sarei entrato in ospedale con il pensiero che l’indomani mi sarei giocato tutto, ma anche con l’idea e la convinzione che avevo passato i 13 anni della mia vita più belli, accanto ad una donna meravigliosa, mia moglie.
Ho varcato la soglia dell’ospedale per la seconda volta sapendo che, nel bene o nel male, non sarei uscito subito. Prima mi ricordo che mi sono fumato una sigaretta, è stata l’ultima. Mi è stata assegnata una nuova suite, sempre nello stesso corridoio: quella in fondo era occupata; adesso capivo il perché della stanza singola, prima pensavo a un colpo di fortuna, adesso ero dentro la mia storia, ero cosciente di quello che avevo e della gravità della situazione. Mia madre da Catania era venuta per starmi ovviamente vicino, talmente vicino che ha pernottato in una stanza di albergo accanto all’ospedale, invece di stare in casa mia: cose da mamma.
Ero pronto.
La notte non ho chiuso occhio, l’infermiera di turno mi ha portato più di un tranquillante per prendere sonno, ma niente; sono rimasto fisso su un canale del digitale terrestre, questa volta il televisore me lo ero portato subito, facendo finta di ascoltare e pensando a milioni di cose. Mi sono preparato al grande giorno, forse potevo uscirne salvo o forse no, poco importava: sapevo che avevo solo una scelta in quel momento ed era quella giusta, ne ero convinto..
La mattina dell’operazione ho visto tutto a rallentatore, ogni preliminare mi è sembrato eterno; la salita in sala operatoria è stata come essere teletrasportati, mi sono ritrovato in un locale e non avevo riferimenti visivi esterni, sapevo solo che eravamo saliti di più piani; ricordo che ho pensato «meglio verso su che verso giù» non so perché, forse ho detto anche una battuta a chi spingeva la barella.
Mi hanno preparato, mettendomi delle calze elastiche, ricordo che l’infermiera mi ha detto che erano antitrombo, mi ha fatto ridere, ma c’era veramente poco da ridere, servivano per la prevenzione della tromboembolia venosa post operatoria. Sul letto operatorio, accanto a me, c’erano molti medici; nonostante le mascherine, ho riconosciuto subito la dottoressa; gli altri cercavo di riconoscerli dai loro occhi, erano parte dei chirurghi e il primario che a turno vedevo in reparto la sera e durante il giro visite. Li sentivo parlare, mi hanno rincuorato, erano tranquilli, loro.
Io un po’ meno, ma è passata subito. Ricordo che quella serenità mi ha aiutato molto. Poi è arrivato l’anestetista che con parole confortanti mi ha messo la maschera di ossigeno, qualche ago in vena e mi ha addormentato.
L’operazione è stata fatta naturalmente sotto anestesia totale e respirazione assistita, l’ultimo ricordo è stato l’orologio della sala operatoria. Una volta sveglio, la prima visione è stata di nuovo l’orologio della sala operatoria: era durata meno di quello che doveva essere. Poi le parole in lontananza, come sottovoce, del primario che mi ha guardato e mi ha detto «mi spiace, non ci siamo riusciti» o una frase del genere. Poi il nulla, in pochissimi secondi ho capito che qualcosa era andato storto, o meglio l’operazione non si era svolta completamente, non erano passate 6 ore.
Non sentivo nessun dolore, mi hanno accompagnato in un’altra stanza accanto alla sala operatoria, non ricordo quanto tempo sono rimasto lì dentro, ma ricordo molto bene il rientro nella mia stanza, il volto di mia moglie, di mia madre, di Dario uno dei miei cugini e di Carmelo mio amico da sempre. Passato un po’ di tempo e ho realizzato di tenere sul viso una maschera di ossigeno, vedevo cavi ovunque e tubicini, sentivo pizzicare nelle parti basse e una rigidezza nella zona addominale, ma ovviamente non sentivo al momento nessun dolore; mi è venuto spontaneo però sorridere, questo me l’ha raccontato mia moglie.
In quei giorni post operazione, ho fatto capire a mia moglie che volevo che mi fotografasse con il telefonino, che mi doveva mostrare la parte dove avevo subito l’operazione: volevo sbirciare come ero, in che condizioni. Vista la ferita per tutto il lato orizzontale del mio addome e tutti quei punti di sutura (che sembravano graffette metalliche, quelle che si usano per le scartoffie, ben fatta) sembrava tutto regolare.
Ricordo che ho pensato «credevo peggio». Il primario, mi ha spiegò bene cosa era successo e di come l’operazione dal nome lunghissimo, si era trasformata in una laparotomia esplorativa, «tutto come da protocollo» mi ha detto. Dopo l’incisione chirurgica mi hanno esplorato l’intero addome con particolare riguardo alla ricerca di eventuali micro metastasi. Il secondo passo, sempre secondo il protocollo prevedeva di confermare o meno l’asportazione della massa e a tal proposito hanno proceduto alla mobilizzazione del duodeno e della testa pancreatica per ricercare eventuali infiltrazioni nell’arteria e/o nella vena mesenterica superiore da parte del tumore. Ecco l’intoppo: l’infiltrazione, che non doveva esserci. L’equipe medica ha asportato del materiale per le biopsie e per essere sicuri del verdetto al 100%.
Da qui ha inizio la seconda parte della mia storia, da questa infiltrazione; in una frase di dieci parole si racchiude ora la mia vita e questa accompagna i referti di ogni esame che faccio o altro: adenocarcinoma alla testa del pancreas in stato avanzato, non operabile. Punto.
Sono rimasto in ospedale fino al 15 dicembre, un tempo infinito.
Primo gennaio del 2014: comincia un nuovo anno, è il compleanno di mia madre, ed io il giorno dopo inizio la mia prima esperienza in Oncologia Medica, il mio primo periodo in un nuovo reparto. Ho cambiato padiglione, ma non ospedale; adesso il Padiglione B deve ospitare me e il mio cancro. La prima impressione del reparto di oncologia al secondo piano è stata buona; mi ricordo le presentazioni di rito con il primario, con la capo sala, simpatica e disponibile. Mi è stato assegnato un numero progressivo, un numero di cartella che da quel giorno mi ha identificato come malato oncologico a tutti gli effetti e un apposito cartellino ha attestato la mia triste posizione; su quel pezzo di carta andavano annotate le date delle sedute di chemioterapia.
Ero spaventato, ma passò il primo mese ed ho messo il primo anello al dito. Non so per quale strano motivo e seguendo quale rituale, ma gli anelli sono aumentati mese dopo mese. Oggi nelle mie mani, oltre la fede, se ne possono contare sedici, come i mesi di terapia che ho superato fino ad oggi.
Esattamente il mio primo periodo di terapia si è svolto così: da gennaio a luglio con un trattamento col protocollo che utilizzava i farmaci gemcitabina e abraxane, sette cicli in totale; poi ad agosto mi hanno sottoposto a un mese di trattamento chemio-radioterapico al Cro (Centro di Riferimento Oncologico) di Aviano in provincia di Pordenone: 15 sedute, hanno voluto provare a sferrare un bel colpo al tumore perché ero riuscito a superare bene il primo periodo senza particolari problemi.
Certo non tutto è filato liscio nel frattempo, ho avuto problemi alle gambe che hanno comportato un lungo periodo di punture alla pancia per contrastare gli edemi, episodi di febbre alta che hanno sfiorato i 41 gradi, tanta nausea: mesi non facili. Mi hanno dovuto sostituire più volte lo stent biliare (una protesi tubolare in plastica o metallica) messo in chirurgia, per favorire il normale deflusso della bile in duodeno: si fa con l’ERCP (colangiopancreatografia retrograda endoscopica); sino a oggi questo intervento l’ho ripetuto già tre volte.
A intervalli regolari sono stato sottoposto a esami diagnostici particolari quali TAC (tomografia assiale computerizzata) e PET (tomografia a emissione di positroni), entrambe con mezzi di contrasto per fotografare bene la situazione: ogni volta per vedere eventuali movimenti o speranzose regressioni che possono cambiare la situazione e modificare quella fastidiosa frase «non-operabile», parole che ogni volta che mi guardo l’addome e la lunga cicatrice, con oltre 50 punti di sutura, mi sembrano assurde, sembra che ho giocato fino ad ora. Forse era meglio l’etichetta «non-rioperabile». Mi sono sottoposto anche ad altri esami, come ecografia cardiaca, scintigrafia polmonare, ecodoppler venosa agli arti inferiori, Angio TAC ai vasi addominali ed ecografie all’addome.
I giorni passavano, naturalmente dovevo fare i check-up con esami del sangue specifici e periodicamente sempre TAC e PET per vedere eventuali movimenti del tumore. Dopo una TAC, ad aprile del 2015, il mio tumore si è ricordato della mia esistenza e mi ha mandato un salutino: ho avuto un peggioramento e dovevo ricominciare la chemioterapia, sono stato ricoverato in chirurgia per l’inserimento di un port, una sorta di valvola da dove si possono somministrare i medicinali chemioterapici (le vene oramai deboli del mio corpo non consentivano più nuove iniezioni) ed è iniziato un secondo periodo di terapia.
Questa volta non potendo rifare il precedente trattamento, il mio oncologo ha scelto un protocollo con maggiore tossicità, ma a suo dire più efficace, in grado di rallentare la progressione del male rispetto anche al trattamento standard. Dovevo urgentemente iniziare un regime chemioterapico a quattro farmaci (oxaliplatino, irinotecan, leucovorina e fluorouracile) folfirinox; naturalmente con il mio consenso ed ho iniziato questa nuova avventura, con la speranza di mettere il bastone tra le ruote al tumore.
Una terapia diversa, con effetti collaterali forti, ho ricevuto tutte le informazioni in merito: il protocollo prevedeva che uno di questi farmaci, l’irinotecan fotosensibile – quindi da tenere al riparo dalla luce – dovesse essere somministrato nell’arco delle 48 ore, quindi oltre alle 5-6 ore di seduta mi portavo a casa take-away la bottiglietta con all’interno quel medicinale: c’era un palloncino che man mano si andava sgonfiando e rilasciava l’infusione nelle mie vene. Era dura, questo giro la vedevo dura.
E cosi è stato. A differenza della precedente chemioterapia ho accusato il colpo, ma mai, dico mai, ho mollato; seguito passo passo dai dottori sono riuscito a metter altri otto anelli alle mie dita. I controlli hanno confermato che il cancro si era stabilizzato e che non avanzava per adesso, pur rimanendo non operabile. Così sono arrivato fino a novembre del 2015 ed ho terminato la terapia; da allora non posso fare più nulla se non tenerlo a bada, fotografarlo a intervalli regolari.
Oggi a distanza di più di 4 anni cosa ci puoi dire
Da quel novembre del 2015 sono entrato in una situazione di equilibrio come un aereo nel momento prima dello stallo, mi viene detto che non è possibile andare oltre, che non si può fare più nulla, che bisogna solo sottoporsi ai controlli periodici e sopravvivere con questo grave tumore. Ho trovato il modo di reagire camminando, questo antico modo di muoversi mi fa star bene e diventa il mio modo di ringraziare la vita nonostante tutto. Ho iniziato con il recarmi in ospedale a piedi da casa mia che dista circa quindici chilometri per poi fare piccole escursioni in montagna fino ad iniziare dei veri e propri cammini. Dal confine Italo-Austriaco di Tarvisio ho percorso a piedi tanta strada, ho valicato l’Appenino Emiliano dal passo di Croce Arcana per arrivare fino a Fucecchio in Toscana, calcando le orme degli antichi pellegrini sulla Romea Strata. Successivamente ho risalito la Via Francigena fino a Sarzana per proseguire fino al confine italo-francese seguendo la Via della Costa. Qualche passo anche in Francia per poi con un treno ho raggiunto Saint Jean Pied de Port ai piedi dei Pirenei per arrivare fino all’oceano Atlantico passando per Santiago di Compostela. In totale 2.248 chilometri percorsi a piedi.
Riporto il diario delle varie tappe del mio cammino sul mio blog, racconto anche gli stop forzati a causa dei controlli che mi ha imposto la malattia e dei “pit-stop” necessari per riprendere le forze. Intervalli e pause che “riempio” con altre escursioni nella Regione che mi ha adottato, il Friuli Venezia Giulia e non solo. Considero la fine di ogni escursione, il termine di ogni trekking, la conclusione di ogni cammino come punto d’inizio per altre mete e non come punto di arrivo. Vivere e sopravvivere con questo fastidioso compagno di viaggio, “se di cancro si muore pur si vive” è il mio motto. Se questo raccontare “il cammino con il cancro” può essere di aiuto anche ad una sola persona, allora alla fine non avrò perso, ma avrò vinto.
E se proprio devo dare i numeri: giorno dopo giorno e passo dopo passo, i chilometri aumentano (ad oggi ho percorso più di 6000km) e anche i giorni che ho la fortuna di vedere in questo mondo aumentano (ho 44 anni e sono nel quinto anno dalla diagnosi della mia malattia). Che altro dire? Buona vita!
Il blog di Andrea Spinelli è: andreaspinelli.it
Recentemente Andrea ha pubblicato un suo libro “Se cammino vivo. Se di cammino si muore pur vive” dove racconta il modo con cui convive con il tumore e combatte lo stigma sociale che aleggia intorno a questa malattia. Il libro è disponibile al seguente indirizzo: