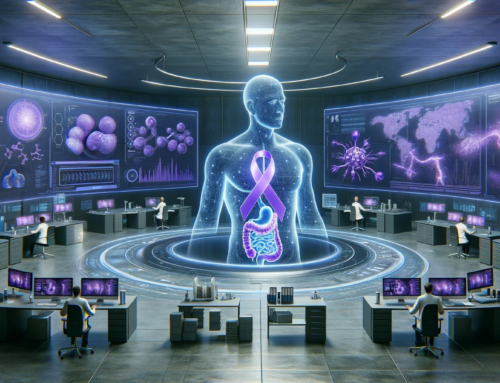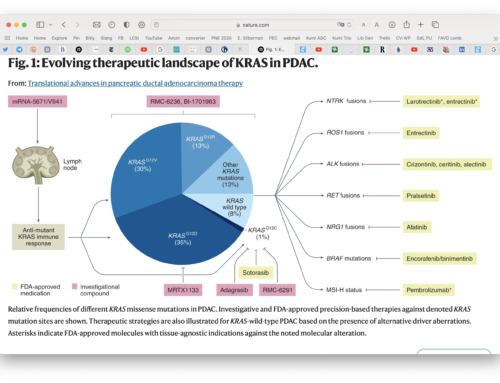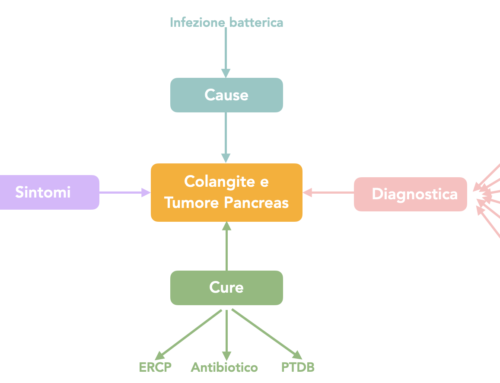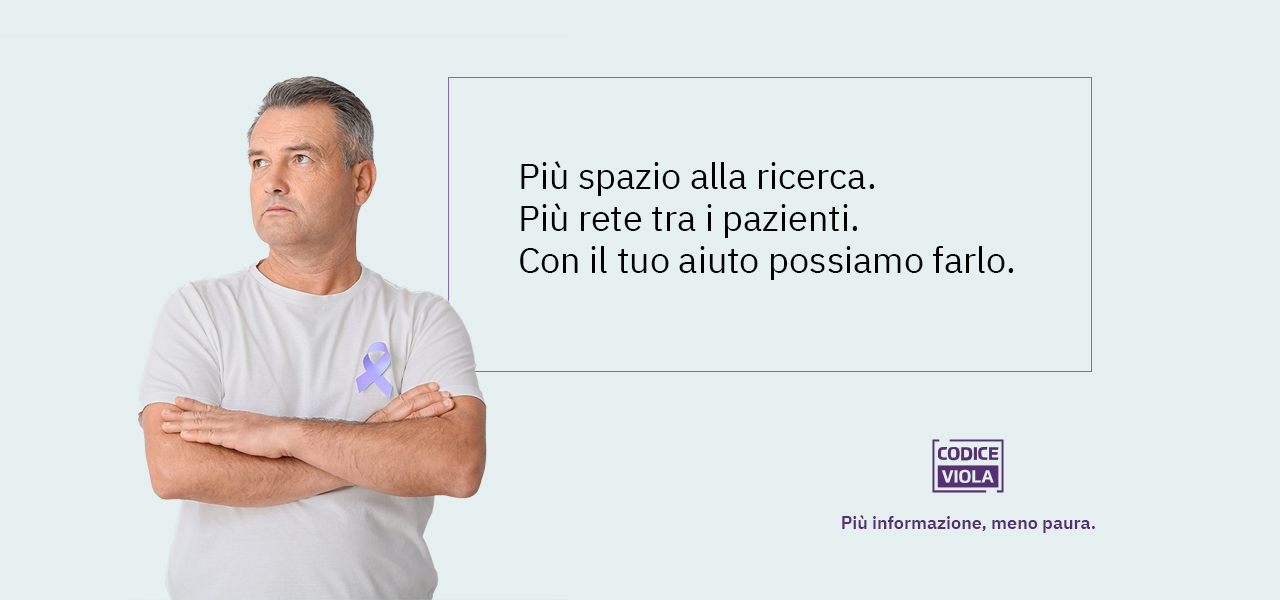Michele Reni è Direttore del Programma Strategico di Coordinamento Clinico, Pancreas Center, IRCCS Ospedale S. Raffaele, Milano. È più comunemente conosciuto e apprezzato nella comunità dei pazienti e dei familiari come uno dei pochi oncologi specializzato sulla cura del tumore del pancreas in Italia. In questa intervista parla dei criteri per scegliere un percorso di cura
Frequentando la comunità dei pazienti di tumore al pancreas e dei familiari la prima figura medica a cui si fa riferimento è quella del chirurgo, spesso anche per quei pazienti per cui il tumore ha già sviluppato metastasi. Cosa può dirci al riguardo?
Fa parte di un retaggio culturale, che nel caso del tumore del pancreas é obsoleto e può essere fuorviante. Tanto per cominciare, solo il 20% dei tumori del pancreas è resecabile laddove tutti i pazienti hanno una potenziale indicazione chemioterapica. Ne consengue che nell’80-85%% dei casi la visita chirurgica si traduce in un ritardo della presa in carico da parte dell’oncologo. Ritardo determinato dal tempo di attesa per la visita chirurgica e, a seguire, dal tempo di attesa per la visita oncologica. Nel caso del tumore del pancreas non possiamo permetterci di sprecare tempo. Inoltre, anche nel 15-20% dei pazienti che hanno un tumore resecabile, coloro che vengono effettivamente resecati, sono circa la metà di quelli inizialmente resecabili. Infatti, alcuni pazienti hanno una progressione di malattia in attesa dell’intervento. Inoltre dal 2 al 20% dei pazienti, in base all’esperienza del centro, muoiono per le complicanze chirurgiche; in un altro 10-15% si riscontrano delle metastasi durante l’intervento, e in altrettanti alla TC post-intervento. Infine, circa il 20% dei pazienti ha un difficoltoso recupero fisico dopo la chirurgia e non è in grado di ricevere altre terapie. Il dato però più eclatante è che, tra la metà dei pazienti che sono riusciti a completare tutto questo iter, solo il 5% guariscono con l’intervento. In altre parole, la chirurgia da sola guarisce circa 3-5 pazienti ogni 1000! Questo succede perché il tumore del pancreas è atipico, ha la caratteristica di diffondersi per il corpo in modo precoce e prevalentemente invisibile attraverso delle micrometastasi. Perciò, dopo l’intervento è indispensabile somministrare una chemioterapia post-operatoria, la cosiddetta chemio adiuvante. In questo modo si riesce a raddoppiare o triplicare il numero delle persone che guariscono. Tuttavia, solo il 50-65% dei pazienti è in grado di completare l’intero percorso di trattamento chemioterapico post-operatorio e, in ogni caso, un ulteriore 15-20% dei pazienti ha una recidiva di malattia nel corso del trattamento postoperatorio e altrettanti entro un anno dalla chirurgia.
Cosa si può ipotizzare di fare allora?
Alla luce di queste informazioni, l’intervento chirurgico come primo approccio terapeutico non sembrerebbe rappresentare la soluzione migliore. Nella maggior parte dei casi potrebbe essere più efficace prima sterilizzare tutto quello che può essere andato in giro e poi togliere il tumore primario. A sostegno di questa ipotesi, abbiamo concluso nel 2018 una sperimentazione multicentrica, PACT-15, con circa novanta di pazienti con adenocarcinoma del pancreas ‘resecabile’ (quindi non solo nel sottogruppo selezionato dei pazienti resecati con successo che hanno recuperato le forze dopo l’intervento). La composizione dei 3 gruppi dei pazienti della sperimentazione era la seguente:
- un terzo dei pazienti ha subito prima l’asportazione del tumore e successivamente la chemioterapia standard (gemcitabina) per 6 mesi,
- un terzo ha subito l’asportazione del tumore seguita dalla combinazione chemioterapica cisplatino, epirubicina, capecitabina, gemcitabina, PEXG, per 6 mesi,
- un terzo si è sottoposto a 3 mesi di PEXG, successivamente è andato all’intervento chirurgico e poi ha fatto altri 3 mesi di PEXG.
La percentuale di pazienti che non avevano avuto una recidiva di malattia dopo un anno dall’inserimento nello studio sono state per i 3 gruppi rispettivamente del:
- 23%
- 50%
- 66%
D’accordo sono numeri piccoli e non forniscono un’evidenza di primo livello, ma un segnale forte e chiaro lo danno.
Un’altra strada che molti seguono è prendere appuntamenti con più medici ricevendo consigli molto diversi. C’è il medico che consiglia l’intervento immediato, quello che consiglia lo schema chemioterapico A, un altro che consiglia lo schema chemioterapico B, per chiudere con il luminare i che propone test genomici. Il paziente o il familiare fino al giorno prima della diagnosi sapeva a malapena dell’esistenza del pancreas e improvvisamente deve scegliere il medico a cui affidarsi .
Questa domanda va al cuore del problema, ma prima voglio dire una cosa riguardo sul luminare che consiglia i test genomici. Non esiste nessuna associazione tra profili genetici e scelta della cura. Un test genomico, che tra l’altro costa al paziente qualche migliaio di euro, nel caso del tumore del pancreas è totalmente inutile perché l’AIFA – giustamente – non autorizza l’uso dei trattamenti oncologici sulla base di questo test non esistendo un’evidenza scientifica a supporto di un favorevole rapporto rischi-benefici per il paziente. Inoltre, se anche questo collegamento ci fosse, e ripeto che così non è, sarebbe un test che dovrebbe richiedere l’oncologo; che senso ha, ad esempio, che lo richieda il chirurgo?
Venendo alla domanda: è vero, succede esattamente questo. Quello di cui c’è bisogno sono centri multidisciplinari, nei quali vari specialisti si confrontano e decidono insieme caso per caso quale approccio abbia le maggiori probabilità di essere il più efficace. Il problema poi è chi garantisce che i centri siano veramente multidisciplinari e non tali solo di nome. Non deve bastare una “autocertificazione”, ci vogliono criteri oggettivi, una specie di certificazione di qualità che attesti che il centro X è multidisciplinare, in particolare con certificazioni nei campi A, B e C. Magari non è possibile che ogni centro abbia eccellenze in tutti i settori, ma è importante che chi ci arriva sappia cosa c’è e cosa non c’è. Ma ripeto che il cuore della questione è che ci sia una certificazione esterna basata su dati oggettivi. Per esempio quante volte il team si riunisce, che percentuale di casi viene discussa collegialmente, quanti pazienti hanno la malattia sotto controllo dopo 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 5 anni ecc..
D’accordo, ma allora ad un centro così come ci si rivolge? Uno telefona e dice: “Buongiorno, voglio un appuntamento con tutto il team”? Chi decide chi vede chi?
Ci dev’essere un call center e delle linee guida. Nella maggioranza dei casi l’iter diagnostico-terapeutico è standardizzato, le situazioni dubbie e problematiche invece devono essere valutate collegialmente. Conta moltissimo anche l’affiatamento del gruppo. Nel nostro caso, per esempio, tra i componenti del team c’è una enorme stima ma ancora di più una profondissima amicizia. La variabilità di indicazioni tra i vari ‘luminari’ dipende dal fatto che la medicina non è matematica e non abbiamo ancora dati oggettivi per capire quando sia meglio un approccio e quando un altro. Qualcuno ha l’intuito, una specie di sesto senso; in assenza di quello dobbiamo spingere la ricerca per trovare degli indicatori oggettivi e nel frattempo coltivare la formazione di team competenti e affiatati.
In molti scelgono il centro in base ai numeri, ai volumi della chirurgia. È un buon criterio?
Dire che i numeri non contino niente sarebbe sbagliato, è chiaro che dove fanno tre operazioni all’anno è meglio non andarci, ma non può essere l’unico criterio. In alcuni casi ci può essere addirittura una correlazione inversa. Mi spiego meglio. Se un centro fa, per esempio, 500 interventi all’anno e un altro ne fa 1000, non è detto che il secondo sia migliore del primo. Magari sono solo meno coscienziosi, magari operano anche persone che invece sarebbe meglio non operare, oppure le operano nel momento sbagliato. Bisognerebbe guardare altri dati oltre alla semplice quantità. Per esempio quante complicanze ci sono in percentuale, quante recidive entro il primo anno ecc. Più difficile invece capire quanti interventi che si sarebbero dovuti fare non sono stati fatti.
Condividi questo articolo

Michele Reni è Direttore del Programma Strategico di Coordinamento Clinico, Pancreas Center, IRCCS Ospedale S. Raffaele, Milano. È più comunemente conosciuto e apprezzato nella comunità dei pazienti e dei familiari come uno dei pochi oncologi specializzato sulla cura del tumore del pancreas in Italia. In questa intervista parla dei criteri per scegliere un percorso di cura
Frequentando la comunità dei pazienti di tumore al pancreas e dei familiari la prima figura medica a cui si fa riferimento è quella del chirurgo, spesso anche per quei pazienti per cui il tumore ha già sviluppato metastasi. Cosa può dirci al riguardo?
Fa parte di un retaggio culturale, che nel caso del tumore del pancreas é obsoleto e può essere fuorviante. Tanto per cominciare, solo il 20% dei tumori del pancreas è resecabile laddove tutti i pazienti hanno una potenziale indicazione chemioterapica. Ne consengue che nell’80-85%% dei casi la visita chirurgica si traduce in un ritardo della presa in carico da parte dell’oncologo. Ritardo determinato dal tempo di attesa per la visita chirurgica e, a seguire, dal tempo di attesa per la visita oncologica. Nel caso del tumore del pancreas non possiamo permetterci di sprecare tempo. Inoltre, anche nel 15-20% dei pazienti che hanno un tumore resecabile, coloro che vengono effettivamente resecati, sono circa la metà di quelli inizialmente resecabili. Infatti, alcuni pazienti hanno una progressione di malattia in attesa dell’intervento. Inoltre dal 2 al 20% dei pazienti, in base all’esperienza del centro, muoiono per le complicanze chirurgiche; in un altro 10-15% si riscontrano delle metastasi durante l’intervento, e in altrettanti alla TC post-intervento. Infine, circa il 20% dei pazienti ha un difficoltoso recupero fisico dopo la chirurgia e non è in grado di ricevere altre terapie. Il dato però più eclatante è che, tra la metà dei pazienti che sono riusciti a completare tutto questo iter, solo il 5% guariscono con l’intervento. In altre parole, la chirurgia da sola guarisce circa 3-5 pazienti ogni 1000! Questo succede perché il tumore del pancreas è atipico, ha la caratteristica di diffondersi per il corpo in modo precoce e prevalentemente invisibile attraverso delle micrometastasi. Perciò, dopo l’intervento è indispensabile somministrare una chemioterapia post-operatoria, la cosiddetta chemio adiuvante. In questo modo si riesce a raddoppiare o triplicare il numero delle persone che guariscono. Tuttavia, solo il 50-65% dei pazienti è in grado di completare l’intero percorso di trattamento chemioterapico post-operatorio e, in ogni caso, un ulteriore 15-20% dei pazienti ha una recidiva di malattia nel corso del trattamento postoperatorio e altrettanti entro un anno dalla chirurgia.
Cosa si può ipotizzare di fare allora?
Alla luce di queste informazioni, l’intervento chirurgico come primo approccio terapeutico non sembrerebbe rappresentare la soluzione migliore. Nella maggior parte dei casi potrebbe essere più efficace prima sterilizzare tutto quello che può essere andato in giro e poi togliere il tumore primario. A sostegno di questa ipotesi, abbiamo concluso nel 2018 una sperimentazione multicentrica, PACT-15, con circa novanta di pazienti con adenocarcinoma del pancreas ‘resecabile’ (quindi non solo nel sottogruppo selezionato dei pazienti resecati con successo che hanno recuperato le forze dopo l’intervento). La composizione dei 3 gruppi dei pazienti della sperimentazione era la seguente:
- un terzo dei pazienti ha subito prima l’asportazione del tumore e successivamente la chemioterapia standard (gemcitabina) per 6 mesi,
- un terzo ha subito l’asportazione del tumore seguita dalla combinazione chemioterapica cisplatino, epirubicina, capecitabina, gemcitabina, PEXG, per 6 mesi,
- un terzo si è sottoposto a 3 mesi di PEXG, successivamente è andato all’intervento chirurgico e poi ha fatto altri 3 mesi di PEXG.
La percentuale di pazienti che non avevano avuto una recidiva di malattia dopo un anno dall’inserimento nello studio sono state per i 3 gruppi rispettivamente del:
- 23%
- 50%
- 66%
D’accordo sono numeri piccoli e non forniscono un’evidenza di primo livello, ma un segnale forte e chiaro lo danno.
Un’altra strada che molti seguono è prendere appuntamenti con più medici ricevendo consigli molto diversi. C’è il medico che consiglia l’intervento immediato, quello che consiglia lo schema chemioterapico A, un altro che consiglia lo schema chemioterapico B, per chiudere con il luminare i che propone test genomici. Il paziente o il familiare fino al giorno prima della diagnosi sapeva a malapena dell’esistenza del pancreas e improvvisamente deve scegliere il medico a cui affidarsi .
Questa domanda va al cuore del problema, ma prima voglio dire una cosa riguardo sul luminare che consiglia i test genomici. Non esiste nessuna associazione tra profili genetici e scelta della cura. Un test genomico, che tra l’altro costa al paziente qualche migliaio di euro, nel caso del tumore del pancreas è totalmente inutile perché l’AIFA – giustamente – non autorizza l’uso dei trattamenti oncologici sulla base di questo test non esistendo un’evidenza scientifica a supporto di un favorevole rapporto rischi-benefici per il paziente. Inoltre, se anche questo collegamento ci fosse, e ripeto che così non è, sarebbe un test che dovrebbe richiedere l’oncologo; che senso ha, ad esempio, che lo richieda il chirurgo?
Venendo alla domanda: è vero, succede esattamente questo. Quello di cui c’è bisogno sono centri multidisciplinari, nei quali vari specialisti si confrontano e decidono insieme caso per caso quale approccio abbia le maggiori probabilità di essere il più efficace. Il problema poi è chi garantisce che i centri siano veramente multidisciplinari e non tali solo di nome. Non deve bastare una “autocertificazione”, ci vogliono criteri oggettivi, una specie di certificazione di qualità che attesti che il centro X è multidisciplinare, in particolare con certificazioni nei campi A, B e C. Magari non è possibile che ogni centro abbia eccellenze in tutti i settori, ma è importante che chi ci arriva sappia cosa c’è e cosa non c’è. Ma ripeto che il cuore della questione è che ci sia una certificazione esterna basata su dati oggettivi. Per esempio quante volte il team si riunisce, che percentuale di casi viene discussa collegialmente, quanti pazienti hanno la malattia sotto controllo dopo 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 5 anni ecc..
D’accordo, ma allora ad un centro così come ci si rivolge? Uno telefona e dice: “Buongiorno, voglio un appuntamento con tutto il team”? Chi decide chi vede chi?
Ci dev’essere un call center e delle linee guida. Nella maggioranza dei casi l’iter diagnostico-terapeutico è standardizzato, le situazioni dubbie e problematiche invece devono essere valutate collegialmente. Conta moltissimo anche l’affiatamento del gruppo. Nel nostro caso, per esempio, tra i componenti del team c’è una enorme stima ma ancora di più una profondissima amicizia. La variabilità di indicazioni tra i vari ‘luminari’ dipende dal fatto che la medicina non è matematica e non abbiamo ancora dati oggettivi per capire quando sia meglio un approccio e quando un altro. Qualcuno ha l’intuito, una specie di sesto senso; in assenza di quello dobbiamo spingere la ricerca per trovare degli indicatori oggettivi e nel frattempo coltivare la formazione di team competenti e affiatati.
In molti scelgono il centro in base ai numeri, ai volumi della chirurgia. È un buon criterio?
Dire che i numeri non contino niente sarebbe sbagliato, è chiaro che dove fanno tre operazioni all’anno è meglio non andarci, ma non può essere l’unico criterio. In alcuni casi ci può essere addirittura una correlazione inversa. Mi spiego meglio. Se un centro fa, per esempio, 500 interventi all’anno e un altro ne fa 1000, non è detto che il secondo sia migliore del primo. Magari sono solo meno coscienziosi, magari operano anche persone che invece sarebbe meglio non operare, oppure le operano nel momento sbagliato. Bisognerebbe guardare altri dati oltre alla semplice quantità. Per esempio quante complicanze ci sono in percentuale, quante recidive entro il primo anno ecc. Più difficile invece capire quanti interventi che si sarebbero dovuti fare non sono stati fatti.
Condividi questo articolo

Michele Reni è Direttore del Programma Strategico di Coordinamento Clinico, Pancreas Center, IRCCS Ospedale S. Raffaele, Milano. È più comunemente conosciuto e apprezzato nella comunità dei pazienti e dei familiari come uno dei pochi oncologi specializzato sulla cura del tumore del pancreas in Italia. In questa intervista parla dei criteri per scegliere un percorso di cura
Frequentando la comunità dei pazienti di tumore al pancreas e dei familiari la prima figura medica a cui si fa riferimento è quella del chirurgo, spesso anche per quei pazienti per cui il tumore ha già sviluppato metastasi. Cosa può dirci al riguardo?
Fa parte di un retaggio culturale, che nel caso del tumore del pancreas é obsoleto e può essere fuorviante. Tanto per cominciare, solo il 20% dei tumori del pancreas è resecabile laddove tutti i pazienti hanno una potenziale indicazione chemioterapica. Ne consengue che nell’80-85%% dei casi la visita chirurgica si traduce in un ritardo della presa in carico da parte dell’oncologo. Ritardo determinato dal tempo di attesa per la visita chirurgica e, a seguire, dal tempo di attesa per la visita oncologica. Nel caso del tumore del pancreas non possiamo permetterci di sprecare tempo. Inoltre, anche nel 15-20% dei pazienti che hanno un tumore resecabile, coloro che vengono effettivamente resecati, sono circa la metà di quelli inizialmente resecabili. Infatti, alcuni pazienti hanno una progressione di malattia in attesa dell’intervento. Inoltre dal 2 al 20% dei pazienti, in base all’esperienza del centro, muoiono per le complicanze chirurgiche; in un altro 10-15% si riscontrano delle metastasi durante l’intervento, e in altrettanti alla TC post-intervento. Infine, circa il 20% dei pazienti ha un difficoltoso recupero fisico dopo la chirurgia e non è in grado di ricevere altre terapie. Il dato però più eclatante è che, tra la metà dei pazienti che sono riusciti a completare tutto questo iter, solo il 5% guariscono con l’intervento. In altre parole, la chirurgia da sola guarisce circa 3-5 pazienti ogni 1000! Questo succede perché il tumore del pancreas è atipico, ha la caratteristica di diffondersi per il corpo in modo precoce e prevalentemente invisibile attraverso delle micrometastasi. Perciò, dopo l’intervento è indispensabile somministrare una chemioterapia post-operatoria, la cosiddetta chemio adiuvante. In questo modo si riesce a raddoppiare o triplicare il numero delle persone che guariscono. Tuttavia, solo il 50-65% dei pazienti è in grado di completare l’intero percorso di trattamento chemioterapico post-operatorio e, in ogni caso, un ulteriore 15-20% dei pazienti ha una recidiva di malattia nel corso del trattamento postoperatorio e altrettanti entro un anno dalla chirurgia.
Cosa si può ipotizzare di fare allora?
Alla luce di queste informazioni, l’intervento chirurgico come primo approccio terapeutico non sembrerebbe rappresentare la soluzione migliore. Nella maggior parte dei casi potrebbe essere più efficace prima sterilizzare tutto quello che può essere andato in giro e poi togliere il tumore primario. A sostegno di questa ipotesi, abbiamo concluso nel 2018 una sperimentazione multicentrica, PACT-15, con circa novanta di pazienti con adenocarcinoma del pancreas ‘resecabile’ (quindi non solo nel sottogruppo selezionato dei pazienti resecati con successo che hanno recuperato le forze dopo l’intervento). La composizione dei 3 gruppi dei pazienti della sperimentazione era la seguente:
- un terzo dei pazienti ha subito prima l’asportazione del tumore e successivamente la chemioterapia standard (gemcitabina) per 6 mesi,
- un terzo ha subito l’asportazione del tumore seguita dalla combinazione chemioterapica cisplatino, epirubicina, capecitabina, gemcitabina, PEXG, per 6 mesi,
- un terzo si è sottoposto a 3 mesi di PEXG, successivamente è andato all’intervento chirurgico e poi ha fatto altri 3 mesi di PEXG.
La percentuale di pazienti che non avevano avuto una recidiva di malattia dopo un anno dall’inserimento nello studio sono state per i 3 gruppi rispettivamente del:
- 23%
- 50%
- 66%
D’accordo sono numeri piccoli e non forniscono un’evidenza di primo livello, ma un segnale forte e chiaro lo danno.
Un’altra strada che molti seguono è prendere appuntamenti con più medici ricevendo consigli molto diversi. C’è il medico che consiglia l’intervento immediato, quello che consiglia lo schema chemioterapico A, un altro che consiglia lo schema chemioterapico B, per chiudere con il luminare i che propone test genomici. Il paziente o il familiare fino al giorno prima della diagnosi sapeva a malapena dell’esistenza del pancreas e improvvisamente deve scegliere il medico a cui affidarsi .
Questa domanda va al cuore del problema, ma prima voglio dire una cosa riguardo sul luminare che consiglia i test genomici. Non esiste nessuna associazione tra profili genetici e scelta della cura. Un test genomico, che tra l’altro costa al paziente qualche migliaio di euro, nel caso del tumore del pancreas è totalmente inutile perché l’AIFA – giustamente – non autorizza l’uso dei trattamenti oncologici sulla base di questo test non esistendo un’evidenza scientifica a supporto di un favorevole rapporto rischi-benefici per il paziente. Inoltre, se anche questo collegamento ci fosse, e ripeto che così non è, sarebbe un test che dovrebbe richiedere l’oncologo; che senso ha, ad esempio, che lo richieda il chirurgo?
Venendo alla domanda: è vero, succede esattamente questo. Quello di cui c’è bisogno sono centri multidisciplinari, nei quali vari specialisti si confrontano e decidono insieme caso per caso quale approccio abbia le maggiori probabilità di essere il più efficace. Il problema poi è chi garantisce che i centri siano veramente multidisciplinari e non tali solo di nome. Non deve bastare una “autocertificazione”, ci vogliono criteri oggettivi, una specie di certificazione di qualità che attesti che il centro X è multidisciplinare, in particolare con certificazioni nei campi A, B e C. Magari non è possibile che ogni centro abbia eccellenze in tutti i settori, ma è importante che chi ci arriva sappia cosa c’è e cosa non c’è. Ma ripeto che il cuore della questione è che ci sia una certificazione esterna basata su dati oggettivi. Per esempio quante volte il team si riunisce, che percentuale di casi viene discussa collegialmente, quanti pazienti hanno la malattia sotto controllo dopo 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 5 anni ecc..
D’accordo, ma allora ad un centro così come ci si rivolge? Uno telefona e dice: “Buongiorno, voglio un appuntamento con tutto il team”? Chi decide chi vede chi?
Ci dev’essere un call center e delle linee guida. Nella maggioranza dei casi l’iter diagnostico-terapeutico è standardizzato, le situazioni dubbie e problematiche invece devono essere valutate collegialmente. Conta moltissimo anche l’affiatamento del gruppo. Nel nostro caso, per esempio, tra i componenti del team c’è una enorme stima ma ancora di più una profondissima amicizia. La variabilità di indicazioni tra i vari ‘luminari’ dipende dal fatto che la medicina non è matematica e non abbiamo ancora dati oggettivi per capire quando sia meglio un approccio e quando un altro. Qualcuno ha l’intuito, una specie di sesto senso; in assenza di quello dobbiamo spingere la ricerca per trovare degli indicatori oggettivi e nel frattempo coltivare la formazione di team competenti e affiatati.
In molti scelgono il centro in base ai numeri, ai volumi della chirurgia. È un buon criterio?
Dire che i numeri non contino niente sarebbe sbagliato, è chiaro che dove fanno tre operazioni all’anno è meglio non andarci, ma non può essere l’unico criterio. In alcuni casi ci può essere addirittura una correlazione inversa. Mi spiego meglio. Se un centro fa, per esempio, 500 interventi all’anno e un altro ne fa 1000, non è detto che il secondo sia migliore del primo. Magari sono solo meno coscienziosi, magari operano anche persone che invece sarebbe meglio non operare, oppure le operano nel momento sbagliato. Bisognerebbe guardare altri dati oltre alla semplice quantità. Per esempio quante complicanze ci sono in percentuale, quante recidive entro il primo anno ecc. Più difficile invece capire quanti interventi che si sarebbero dovuti fare non sono stati fatti.